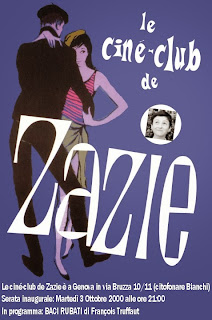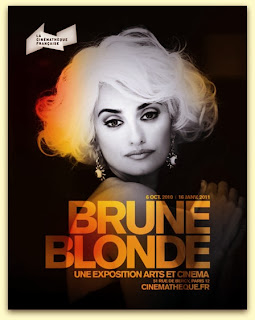In generale, si tratta di “magnifiche ossessioni”, essendo legate a film o, in anni più recenti (diciamo da Six Feet Under in poi), a serie TV. Quando ero più giovane credevo che con l’avanzare dell’età questa cosa mi sarebbe passata, che sarei diventata più saggia, che avrei smesso di provare questi entusiasmi colorati e prolungati, durante i quali tutto il resto si annulla, si annacqua, o mi annoia profondamente. Non è andata così. E oggi, all’alba dei miei (favolosi, ça va sans dire) 50 anni, posso tranquillamente affermare che continuo a vivere queste passioni furibonde con lo stesso grado di follia momentanea di quando di anni ne avevo 15 o 20.
Sarà una brutta o una bella cosa? Mi chiedo spesso. Vorrà dire che non riesco a crescere? Che mi rifiuto di diventare più posata? Eh, non lo so, ma dato che non ci posso fare molto, eccomi qui, prendere o lasciare. In questo blog, ai miei lettori ho ciclicamente propinato post entusiasmanti su questo o quel film, questo o quell’attore, questo o quel regista, questa o quella serie. Tutti questi amori si sono negli anni accumulati, si sono allineati uno di fianco all’altro, formando un piccolo e privato pantheon di idoli assoluti.
La felicità che mi procura avere un nuovo, incontenibile entusiasmo, è sempre stata ai primi posti in classifica, nella mia vita. L’unica cosa che forse è cambiata, con lo scorrere del tempo, è la frequenza con cui queste cose accadono. Si è più esigenti, presumo, si è più sicuri dei propri gusti, si riconoscono meglio i propri simili. Ma poi, sempre, arriva il giorno che BOUM!, succede, e allora non ce n’è più per nessuno.
Da tempo leggevo sulla stampa inglese articoli entusiasti su questa ragazza, Phoebe Waller-Bridge, e la serie TV di cui era autrice e protagonista, Fleabag (Sacco di pulci). Ne leggevo ma nessuno intorno a me la stava guardando, o me ne parlava, e allora avevo lasciato correre. Poi pochi mesi fa sul Guardian hanno iniziato a scrivere delle cose pazzesche sulla seconda stagione della serie, culminate in un pezzo in cui, a pochi giorni dalla fine della sua messa in onda, davano delle istruzioni per riuscire a sopravvivere alla fine della stessa.
Il grado di idolatria che sprigionava da questi articoli è suonato come una chiamata alle armi. Una sirena rossa si è messa a lampeggiare: Warning! Warning! nuovo possibile entusiasmo all’orizzonte.
Così mi sono decisa a guardare la prima stagione.
Non è stato, come molti potrebbero pensare, amore a prima vista. Anzi.
Sono rimasta sconvolta dai primissimi minuti della serie, dalla crudezza con cui Fleabag si mette a nudo, da quella domanda assurda che fa a se stessa e al pubblico (perché la protagonista ha il vezzo di rivolgersi direttamente allo spettatore guardando dritta nella camera da presa) seduta in un caffè, ancora prima del titolo, ancora prima della sigla (che poi non esiste nemmeno, una vera sigla, ti butta lì il titolo con sotto una musica assordante come a dire: e chi se ne importa di quelle belle sigle tutte super design quando ti ho appena fissato dallo schermo per chiedermi/chiederti: Do I have a massive asshole? Letteralmente: Ho un buco del culo enorme?).
Insomma Fleabag è respingente. Non è l’eroina nella quale ti vuoi facilmente identificare, anzi ti mette così a disagio che pensi: oddio, io non sono ASSOLUTAMENTE come lei!
Quindi ho visto i primi due episodi e ho mollato lì. E poi, una sera, non so perché, era Giugno, ho sentito che quella partita non era finita, che anzi doveva ancora iniziare.
Ho guardato tutto di nuovo dall’inizio e ad un certo punto è scattato qualcosa: BANG!, e nel giro di poche ore avevo visto per intero la prima e la seconda serie, senza riuscire a fermarmi (non è un’impresa impossibile, le due stagioni sono composte di 6 episodi ciascuna di circa 20-25 minuti l’uno).
E da allora, niente, c’è un prima e c’è un dopo Fleabag.
Fleabag racconta di una ragazza di circa 30 anni che vive a Londra e gestisce un caffè, che ha una relaziono on/off con un ragazzo gentile ma un po’ bizzarro, che ha un sacco di incontri sessuali con gente ancora più bizzarra, che ha una famiglia composta da padre, nuova compagna del padre (una stronza micidiale interpretata divinamente da Olivia Colman, l'attrice Premio Oscar 2019), sorella e marito della sorella (più figlio acquisito di quest’ultimo), che ha perso da poco la madre e la migliore amica (con la quale aveva aperto il caffè) e che queste due cose la fanno soffrire tantissimo. Fleabag ha uno spiccato sense of humour, molto british e molto trash, ha la capacità di dire tutto quello che pensa nella maniera più indigesta possibile per gli altri (e pure per se stessa), e alla fine della prima stagione sta letteralmente andando in pezzi.
Basato su un one-woman-show che la Waller-Bridge aveva portato al Fringe Festival di Edimburgo qualche anno fa, e che aveva generato tanto entusiasmo da indurre la BBC a chiederle di farne una serie TV, Fleabag era destinato ad essere un esperimento da una stagione sola. Visto il successo, la BBC ha cominciato ad insistere perché la storia di questo sacchetto di pulci avesse un seguito. Dapprima restìa, la Waller-Bridge racconta di avere avuto una vera e propria illuminazione, di aver avuto L’IDEA, e che solo a quel punto ha accettato di far continuare la storia.
Sono poche, ammettiamolo, le serie TV che hanno una seconda stagione più bella della prima. Fleabag fa eccezione.
Se la prima stagione è bellissima, la seconda è straordinaria, anzi di più, è perfetta (e infatti non avrà un seguito, perché sarebbe impossibile concepire una cosa altrettanto geniale, o forse - come lei stessa afferma - si potrà fare tra 20 anni, per vedere che cosa mai avrà combinato questa donna nel frattempo).
Tra la prima e la seconda stagione, nella finzione, è passato poco più di un anno.
Un anno nel quale Fleabag ha cercato di cambiare, di migliorare, di crescere: la relazione on/off è definitivamente terminata, non scopa più in giro, mangia sano, fa sport e il caffè che gestisce ha preso a funzionare. Le cose con la famiglia sono messe un tantino peggio. Con la matrigna non va benissimo e, soprattutto, non parla con la sorella dalla fine della prima stagione.
Il primo episodio di Fleabag 2, io ve lo dico, dovrebbe essere studiato in qualsiasi scuola di sceneggiatura di questo mondo come esempio straordinario di scrittura.
E’ una cena. Una semplice cena di famiglia, dove tutti sono riuniti (in un ristorante), per festeggiare l’avvenimento dell’anno: l’imminente matrimonio tra il padre di Fleabag e l’insopportabile compagna. Finirà in un massacro, metafisico e fisico, ma anche in una cosa totalmente inaspettata, come del resto ci promette Fleabag all’inizio dell’episodio, una scena memorabile in cui, con il volto insanguinato e tumefatto guarda verso la telecamera e annuncia: This is a love story! (Questa è una storia d’amore!).
E ovviamente non poteva che essere una storia d’amore in puro stile Waller-Bridge.
Perché cosa mai ci potrebbe essere di più profondamente déplacé, assurdo, sconveniente e disperante che innamorarsi del prete cattolico che sta per sposare tuo padre?
E dunque eccolo, il personaggio destinato a cambiare tutto, questa figura di cool (but very hot) priest, che fuma, beve (decisamente troppo), è minacciato dalle volpi (una vera ossessione) e dice parolacce che neanche uno scaricatore di porto.
Ma tanto basta.
Lui e Fleabag sullo schermo fanno letteralmente scintille, e il loro rapporto trasfigura entrambi, lì, sotto i nostri occhi increduli, mentre stiamo a metà tra le risate e le lacrime, e il desiderio potente che tutto questo non abbia mai fine. Anche perché, senza quasi darci il tempo di rendercene conto, succede una cosa sconvolgente che non voglio spoilerare ma che è da cascare dalla sedia. Tenetevi forte, questa donna ha la capacità di stupirvi ad ogni scena. Disseminato di nuovi, meravigliosi personaggi (una psicologa intepretata dalla magnifica Fiona Shaw, una manager intepretata dalla grandiosa Kristin Scott-Thomas, alla quale la Waller-Bridge affida uno dei monologhi femministi più riusciti della storia), Fleabag 2 si snoda ad un ritmo vorticoso, un’idea geniale dietro l’altra, un crescendo di situazioni e assurdità varie, che non lasciano mai la presa, fino alla fine. Che è devastante.
C’è gente che non s’è più ripresa, ve lo giuro (gli attori hanno dovuto girarla almeno tre volte, perché le prime due non facevano altro che piangere).
E capisco perfettamente perché.
Per la parte del prete, Waller-Bridge ha pensato ad un attore non famosissimo, con il quale aveva lavorato 10 anni prima, e il cui carisma inaudito le era rimasto sempre impresso: l’irlandese Andrew Scott. Reputatissimo attore teatrale (il suo Amleto un paio d’anni fa all’Almeida Theatre di Londra ha mandato i critici in visibilio), Scott ha iniziato ad avere un nutrito gruppo di fans soprattutto grazie alla sua interpretazione flamboyante del cattivissimo James Moriarty, la nemesi di Sherlock Holmes nella serie TV Sherlock con Benedict Cumberbatch. Il suo ‘Honey, you should see me in a crown!’ (Dolcezza, mi dovresti vedere con una corona in testa!), ha generato un numero di meme sconsiderati, ed un interesse spasmodico sull’ambiguità sessuale del suo personaggio (diciamo che l’attrazione di Sherlock per lui travarica un po’ il confine dell’eterosessualità). Nella vita reale, Scott è apertamente gay, attivo nel sostegno alla causa LGBT, ma si dichiara felicissimo di interpretare ruoli da etero, come quello che gli ha proposto Waller-Bridge (ha accettato la parte prima che lei scrivesse la sceneggiatura, fidandosi ciecamente del talento dell’amica).
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’alchimia tra i due è semplicemente pazzesca e la hotness del prete a rischio infarto. Se pensate che sto esagerando, fidatevi della dichiarazione di un sito porno inglese: la ricerca di film con pratagonisti dei preti sul loro sito è aumentata del 125% dopo la messa in onda di Fleabag 2. E su Twitter, sotto il mitico #hotpriest, sono state dette per settimane le cose più irriverenti che si possano immaginare.
Il problema vero di quando si guarda Fleabag, in effetti, è il dopo.
Sarà una brutta o una bella cosa? Mi chiedo spesso. Vorrà dire che non riesco a crescere? Che mi rifiuto di diventare più posata? Eh, non lo so, ma dato che non ci posso fare molto, eccomi qui, prendere o lasciare. In questo blog, ai miei lettori ho ciclicamente propinato post entusiasmanti su questo o quel film, questo o quell’attore, questo o quel regista, questa o quella serie. Tutti questi amori si sono negli anni accumulati, si sono allineati uno di fianco all’altro, formando un piccolo e privato pantheon di idoli assoluti.
La felicità che mi procura avere un nuovo, incontenibile entusiasmo, è sempre stata ai primi posti in classifica, nella mia vita. L’unica cosa che forse è cambiata, con lo scorrere del tempo, è la frequenza con cui queste cose accadono. Si è più esigenti, presumo, si è più sicuri dei propri gusti, si riconoscono meglio i propri simili. Ma poi, sempre, arriva il giorno che BOUM!, succede, e allora non ce n’è più per nessuno.
Da tempo leggevo sulla stampa inglese articoli entusiasti su questa ragazza, Phoebe Waller-Bridge, e la serie TV di cui era autrice e protagonista, Fleabag (Sacco di pulci). Ne leggevo ma nessuno intorno a me la stava guardando, o me ne parlava, e allora avevo lasciato correre. Poi pochi mesi fa sul Guardian hanno iniziato a scrivere delle cose pazzesche sulla seconda stagione della serie, culminate in un pezzo in cui, a pochi giorni dalla fine della sua messa in onda, davano delle istruzioni per riuscire a sopravvivere alla fine della stessa.
Il grado di idolatria che sprigionava da questi articoli è suonato come una chiamata alle armi. Una sirena rossa si è messa a lampeggiare: Warning! Warning! nuovo possibile entusiasmo all’orizzonte.
Così mi sono decisa a guardare la prima stagione.
Sono rimasta sconvolta dai primissimi minuti della serie, dalla crudezza con cui Fleabag si mette a nudo, da quella domanda assurda che fa a se stessa e al pubblico (perché la protagonista ha il vezzo di rivolgersi direttamente allo spettatore guardando dritta nella camera da presa) seduta in un caffè, ancora prima del titolo, ancora prima della sigla (che poi non esiste nemmeno, una vera sigla, ti butta lì il titolo con sotto una musica assordante come a dire: e chi se ne importa di quelle belle sigle tutte super design quando ti ho appena fissato dallo schermo per chiedermi/chiederti: Do I have a massive asshole? Letteralmente: Ho un buco del culo enorme?).
Insomma Fleabag è respingente. Non è l’eroina nella quale ti vuoi facilmente identificare, anzi ti mette così a disagio che pensi: oddio, io non sono ASSOLUTAMENTE come lei!
Quindi ho visto i primi due episodi e ho mollato lì. E poi, una sera, non so perché, era Giugno, ho sentito che quella partita non era finita, che anzi doveva ancora iniziare.
Ho guardato tutto di nuovo dall’inizio e ad un certo punto è scattato qualcosa: BANG!, e nel giro di poche ore avevo visto per intero la prima e la seconda serie, senza riuscire a fermarmi (non è un’impresa impossibile, le due stagioni sono composte di 6 episodi ciascuna di circa 20-25 minuti l’uno).
E da allora, niente, c’è un prima e c’è un dopo Fleabag.
Fleabag racconta di una ragazza di circa 30 anni che vive a Londra e gestisce un caffè, che ha una relaziono on/off con un ragazzo gentile ma un po’ bizzarro, che ha un sacco di incontri sessuali con gente ancora più bizzarra, che ha una famiglia composta da padre, nuova compagna del padre (una stronza micidiale interpretata divinamente da Olivia Colman, l'attrice Premio Oscar 2019), sorella e marito della sorella (più figlio acquisito di quest’ultimo), che ha perso da poco la madre e la migliore amica (con la quale aveva aperto il caffè) e che queste due cose la fanno soffrire tantissimo. Fleabag ha uno spiccato sense of humour, molto british e molto trash, ha la capacità di dire tutto quello che pensa nella maniera più indigesta possibile per gli altri (e pure per se stessa), e alla fine della prima stagione sta letteralmente andando in pezzi.
Basato su un one-woman-show che la Waller-Bridge aveva portato al Fringe Festival di Edimburgo qualche anno fa, e che aveva generato tanto entusiasmo da indurre la BBC a chiederle di farne una serie TV, Fleabag era destinato ad essere un esperimento da una stagione sola. Visto il successo, la BBC ha cominciato ad insistere perché la storia di questo sacchetto di pulci avesse un seguito. Dapprima restìa, la Waller-Bridge racconta di avere avuto una vera e propria illuminazione, di aver avuto L’IDEA, e che solo a quel punto ha accettato di far continuare la storia.
Sono poche, ammettiamolo, le serie TV che hanno una seconda stagione più bella della prima. Fleabag fa eccezione.
Se la prima stagione è bellissima, la seconda è straordinaria, anzi di più, è perfetta (e infatti non avrà un seguito, perché sarebbe impossibile concepire una cosa altrettanto geniale, o forse - come lei stessa afferma - si potrà fare tra 20 anni, per vedere che cosa mai avrà combinato questa donna nel frattempo).
Tra la prima e la seconda stagione, nella finzione, è passato poco più di un anno.
Un anno nel quale Fleabag ha cercato di cambiare, di migliorare, di crescere: la relazione on/off è definitivamente terminata, non scopa più in giro, mangia sano, fa sport e il caffè che gestisce ha preso a funzionare. Le cose con la famiglia sono messe un tantino peggio. Con la matrigna non va benissimo e, soprattutto, non parla con la sorella dalla fine della prima stagione.
Il primo episodio di Fleabag 2, io ve lo dico, dovrebbe essere studiato in qualsiasi scuola di sceneggiatura di questo mondo come esempio straordinario di scrittura.
E’ una cena. Una semplice cena di famiglia, dove tutti sono riuniti (in un ristorante), per festeggiare l’avvenimento dell’anno: l’imminente matrimonio tra il padre di Fleabag e l’insopportabile compagna. Finirà in un massacro, metafisico e fisico, ma anche in una cosa totalmente inaspettata, come del resto ci promette Fleabag all’inizio dell’episodio, una scena memorabile in cui, con il volto insanguinato e tumefatto guarda verso la telecamera e annuncia: This is a love story! (Questa è una storia d’amore!).
E ovviamente non poteva che essere una storia d’amore in puro stile Waller-Bridge.
Perché cosa mai ci potrebbe essere di più profondamente déplacé, assurdo, sconveniente e disperante che innamorarsi del prete cattolico che sta per sposare tuo padre?
E dunque eccolo, il personaggio destinato a cambiare tutto, questa figura di cool (but very hot) priest, che fuma, beve (decisamente troppo), è minacciato dalle volpi (una vera ossessione) e dice parolacce che neanche uno scaricatore di porto.
Ma tanto basta.
Lui e Fleabag sullo schermo fanno letteralmente scintille, e il loro rapporto trasfigura entrambi, lì, sotto i nostri occhi increduli, mentre stiamo a metà tra le risate e le lacrime, e il desiderio potente che tutto questo non abbia mai fine. Anche perché, senza quasi darci il tempo di rendercene conto, succede una cosa sconvolgente che non voglio spoilerare ma che è da cascare dalla sedia. Tenetevi forte, questa donna ha la capacità di stupirvi ad ogni scena. Disseminato di nuovi, meravigliosi personaggi (una psicologa intepretata dalla magnifica Fiona Shaw, una manager intepretata dalla grandiosa Kristin Scott-Thomas, alla quale la Waller-Bridge affida uno dei monologhi femministi più riusciti della storia), Fleabag 2 si snoda ad un ritmo vorticoso, un’idea geniale dietro l’altra, un crescendo di situazioni e assurdità varie, che non lasciano mai la presa, fino alla fine. Che è devastante.
C’è gente che non s’è più ripresa, ve lo giuro (gli attori hanno dovuto girarla almeno tre volte, perché le prime due non facevano altro che piangere).
E capisco perfettamente perché.
Per la parte del prete, Waller-Bridge ha pensato ad un attore non famosissimo, con il quale aveva lavorato 10 anni prima, e il cui carisma inaudito le era rimasto sempre impresso: l’irlandese Andrew Scott. Reputatissimo attore teatrale (il suo Amleto un paio d’anni fa all’Almeida Theatre di Londra ha mandato i critici in visibilio), Scott ha iniziato ad avere un nutrito gruppo di fans soprattutto grazie alla sua interpretazione flamboyante del cattivissimo James Moriarty, la nemesi di Sherlock Holmes nella serie TV Sherlock con Benedict Cumberbatch. Il suo ‘Honey, you should see me in a crown!’ (Dolcezza, mi dovresti vedere con una corona in testa!), ha generato un numero di meme sconsiderati, ed un interesse spasmodico sull’ambiguità sessuale del suo personaggio (diciamo che l’attrazione di Sherlock per lui travarica un po’ il confine dell’eterosessualità). Nella vita reale, Scott è apertamente gay, attivo nel sostegno alla causa LGBT, ma si dichiara felicissimo di interpretare ruoli da etero, come quello che gli ha proposto Waller-Bridge (ha accettato la parte prima che lei scrivesse la sceneggiatura, fidandosi ciecamente del talento dell’amica).
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’alchimia tra i due è semplicemente pazzesca e la hotness del prete a rischio infarto. Se pensate che sto esagerando, fidatevi della dichiarazione di un sito porno inglese: la ricerca di film con pratagonisti dei preti sul loro sito è aumentata del 125% dopo la messa in onda di Fleabag 2. E su Twitter, sotto il mitico #hotpriest, sono state dette per settimane le cose più irriverenti che si possano immaginare.
Il problema vero di quando si guarda Fleabag, in effetti, è il dopo.
Perché la serie lascia una sorta di vuoto cosmico che io prima di oggi ho sentito solo alla fine di Six Feet Under e Mad Men, vale a dire delle due esperienze di serie TV che più mi hanno marcato nella vita. Però attenzione, la differenza è abissale, perché quelle due serie avevano rispettivamente 5 e 7 stagioni, con 10-13 puntate a stagione di almeno un'ora ciascuna. Qui no. Il vuoto cosmico è sproporzionato alla durata della serie, ma tant'è.
La prima cosa, la più ovvia, è stata quella di mettersi a rivederne dei lunghi pezzi. Sì, ma poi? E' stato a quel punto che, in preda alla disperazione, ho scritto uno status sulla mia pagina Facebook alla ricerca di orfani di Fleabag, tra l'altro nel momento peggiore, quello in cui la gente parlava senza sosta della fine di Game of Thrones. Alcune amiche, per fortuna, mi sono venute in soccorso. Noi, felici poche. Noi, manipolo di sorelle (no, dico, cito l'Enrico V di Shakespeare che se lo sapesse Andrew Scott sverrebbe!). E' stato grazie ad una di loro che ho scoperto che in questo periodo Scott era a teatro a Londra, in una pièce di Noël Coward: Present Laughter, all'Old Vic. Inutile dirvi che dopo circa due ore mi ero comprata un biglietto, e mi ero organizzata un week-end a Londra.
Ma ancora non mi bastava.
La vera svolta è stata la scoperta, su FB, di FLEABAG - THE OFFICIAL GROUP.
Ed è lì che la mia vita è cambiata, perché ho scoperto di non essere sola.
Ma ancora non mi bastava.
La vera svolta è stata la scoperta, su FB, di FLEABAG - THE OFFICIAL GROUP.
Ed è lì che la mia vita è cambiata, perché ho scoperto di non essere sola.
Perché c'è sempre il momento semi-serio in cui ti chiedi: ma sarò pazza? Ed è così meraviglioso scoprire che, eventualmente, sei pazza insieme ad altre migliaia di persone sparse ovunque sul globo terracqueo (perché vi assicuro, una delle prime cose che ho letto era un post di questa ragazza che chiedeva: ma di dove siete, gente là fuori? e dalla Nuova Zelanda al Nuovo Messico, passando per Taiwan e l'Islanda, c'era tutto il mondo). Ed è così che da settimane il mio buon umore è assicurato da questo gruppetto assurdo di gente che passa il tempo a scrivere cose che io trovo assolutamente esilaranti. Qui citerò una serie di cose totalmente incomprensibili per chi non ha visto la serie, ma si tratta di gente che parla di guinea pigs, volpi, lattine di G&T, dove trovare portachiavi a forma di scultura di busto di donna, tote bags con la scritta: Hair is everything, Anthony (I capelli sono tutto, Anthony), gente che organizza Fleabags Quiz nei pub di Londra, che intavola conversazioni perché è "Chatty Wednesday", che pone delle domande tipo: Ma cosa fate nel caso in cui i vostri colleghi a cui avete consigliato di vedere la serie vi dicono che non l'hanno amata? E la risposta, inevitabile, è: Devi semplicemente cambiare lavoro, cara! O ancora: Mio marito non ama la serie. Sto preparando le carte per il divorzio!
Poi ditemi voi se non è buon umore assicurato per il resto della giornata...
Quando sono andata a vedere Andrew Scott a teatro, l'ho aspettato più di un'ora al freddo e al vento insieme ad un folto gruppo di ragazze visibilmente più giovani di me. Abbiamo fatto una foto insieme e quando l'ho postata sulla pagina dell'official group, nel giro di 10 minuti avevo quasi 350 I Like. Potere dell'Hot Priest, e del culto che gli riserviamo. E io mi sono sentita finalmente compresa.
Mi chiedo spesso: come mai le persone amano così tanto questa seconda stagione?
Lasciando da parte le considerazioni ovvie, su quanto sia scritta e interpretata bene, sulla genialità della sceneggiatura, sulle battute meravigliose, penso che l'elemento che fa la differenza siano loro due. E' la loro storia d'amore. Molto banalmente, siamo tutti alla ricerca di qualcuno in grado di vederci per quello che siamo, al di là di ogni apparenza, di ogni sbaglio, di ogni difetto, dei casini che siamo capaci di generare, delle nostre meschinerie, delle piccolezze e delle nostre paure. E questi due si vedono, eccome se si vedono.
Qualche volta mi chiedo anche: perché non posso vivere come fa tanta gente una vita normale, dove non c'è mai bisogno di andare al cinema, di vedere serie TV, di leggere dei libri? Vite che scorrono lungo i binari dei giorni, non per forza sempre uguali, ma ben ancorate alla realtà, al quotidiano, alle cose da fare, al cibo da cucinare. La risposta è che non lo so. Non lo so perché ho questo bisogno profondo di altro. Di uscire da me. Di adorare l'idea di vivere altre vite. Ma un paio di settimane fa ho visto il nuovo film di Woody Allen e ad un certo punto lui fa pronunciare una frase ad una delle protagoniste che a me è parsa fondamentale e che diceva più o meno così: La vita reale è per quelli che non sanno inventarsi niente di meglio.
Non ne sono sicurissima ma mi piace tantissimo pensarlo.
E se non sono riuscita a farvi venire voglia, dopo tutto questo sproloquio, di correre a vedere Fleabag, allora non sono servita proprio a niente.
E dunque mettetevi pure a guardare qualsiasi altra serie, fate come se niente fosse, io me ne torno dal mio nuovo gruppo di amici a sospirare sulla bellezza del collo di Andrew Scott, mentre parte in sottofondo un doveroso Kyrie Eleison.
Amen!